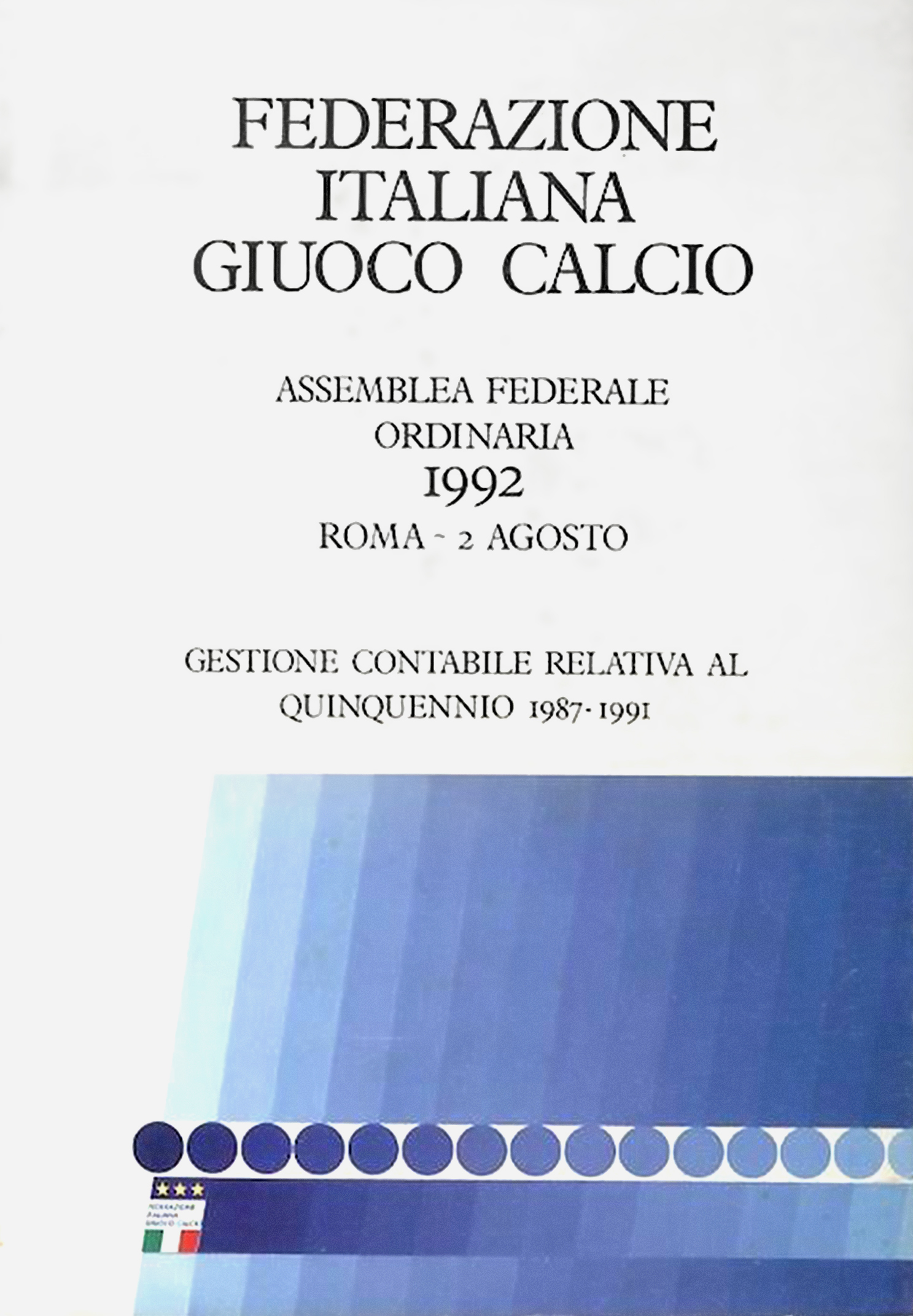PROGETTO GRAFICO n°
Giugno / 2019
Nel luglio 1991, a un anno dall’“estate italiana” cantata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, la rivista di graphic design “Linea Grafica” mostra per la prima volta sulle sue pagine la nuova identità visiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC – tracciando un ritratto della sua autrice: Patrizia Pataccini. Nell’articolo si descrive la designer di base a Milano come «una giovane signora che non rassomiglia in alcun modo al modello di donna-manager che gli Anni ‘80 ci hanno fornito come archetipo della nuova professionalità femminile, né tantomeno al suo contrario, cioè all’artista svagata e sognatrice i cui progetti siano connotati da una forte riconoscibilità; si presenta invece come un’efficiente professionista che non indulge, neppure nell’aspetto, a vezzi superflui.»[1]
Patrizia Pataccini nasce a Milano nel 1951. Frequenta il corso di scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e, dopo una breve parentesi londinese, rientra nel capoluogo lombardo dove comincia a collaborare con lo studio GPI Cortesi, al cui interno presto diventa responsabile del settore grafico.[2] Nel corso degli anni si specializza progressivamente nella costruzione di corporate identity complesse, focalizzandosi in particolare sullo studio di applicazioni del marchio nello spazio, di archigrafie e di sistemi di wayfinding.[3]
Al concorso indetto dalla FIGC per la realizzazione di una nuova corporate identity alle soglie del nuovo campionato europeo, Patrizia Pataccini si presenta con una “i” stilizzata, concepita come sintesi della parola “Italia”. Il marchio proposto dalla designer è composto da un rettangolo inclinato, diviso orizzontalmente in tre fasce: una a fondo azzurro occupata da tre stelle gialle, una a fondo bianco con la dicitura della Federazione di colore azzurro e in carattere sans serif – in due varianti: per esteso e sintetizzata con acronimo –, una con il tricolore italiano. Completa il marchio il puntino sulla “i”, un cerchio azzurro posto in alto a sinistra.
Come era già accaduto nel 1984 con il restyling dell’identità visiva FIGC – invariata fino ai mondiali Italia 90 – anche in questo caso il nuovo logo abbandona l’identificazione dello stemma con lo scudo tricolore. Inoltre, il marchio proposto da Patrizia Pataccini, come quello subito precedente, mantiene l’inclinazione orizzontale della bandiera e insieme dell’apparato tipografico, accentuando il dinamismo complessivo della “i” italic.
Per quanto del logo si parli nel 1991 in quella che allora era la principale rivista italiana di graphic design e nonostante la “i” disegnata dalla designer rimanga per nove anni sulle maglie degli Azzurri – per un totale di due europei e due mondiali persi ai rigori – non si hanno tracce né del percorso professionale di Patrizia Pataccini né della sua corporate identity per la FIGC nelle storie della grafica. Solo sul sito Museodelmarchio.it, nel focus dedicato all’evoluzione del logo della Federcalcio, si fa accenno all’autrice e al suo progetto, riportando però il cognome sbagliato: “Pattacini” anziché Pataccini.[4]
Di recente il logo FIGC usato dalla nazionale italiana dal 1991 al 2000, è ricomparso quasi in simultanea su alcuni capi di abbigliamento prodotti da due brand diversi. Il marchio Lack of Guidance, di base ad Amsterdam e interessato all’ibridazione tra calcio e moda, ha proposto una maglia a maniche lunghe grigio melange chiamata Azzurri in cui, al posto della scritta “Federazione Italiana Giuoco Calcio”, compare il nome del brand composto su due righe.[5]
Quasi contemporaneamente la joint venture tra il marchio milanese Iuter e No Kiddin’ NYC, ha dato vita a una capsule collection composta da una maglia da calcio e da una tuta sportiva, entrambe ispirate dalla divisa degli Azzurri al mondiale di calcio statunitense del 1994.[6] In questo caso il marchio della FIGC disegnato da Patrizia Pataccini viene riproposto con cinque stelle anziché tre e con la dicitura che, al posto di quella ufficiale della Federcalcio, sulla maglia diventa “Campioni del mondo” e sulla tuta è “Iuter”.[7]
Negli ultimi anni si è assisto a una frequente osmosi tra calcio e moda: squadre che presentano le divise stagionali utilizzando il lessico e i canali del fashion, maglie sold-out prima ancora di essere indossate dai giocatori sul campo – si veda il caso della divisa Nigeriana prodotta da Nike per i mondiali russi dello scorso anno –, marchi sportwear che lanciano capsule collection firmate insieme a colossi dell’alta moda o a brand streetwear. Come, tra gli altri, ha affermato “i-D” a proposito dell’eredità di Umbro,[8] Il successo del fenomeno del “football fashion” deve certamente molto a una spiccata indole nostalgica. Proprio questo sentimento diventa determinante nel recupero di elaborati dagli archivi storici o dalla memoria storica come è accaduto al logo di Patrizia Pataccini. Per quanto neppure i brand sopra citati menzionino in alcun modo l’autrice, almeno permettono al suo marchio FIGC di rivivere nella memoria collettiva, di presentarsi alle nuove generazioni e concede ai designer grafici e agli storici di riscoprire un elaborato in gran parte dimenticato dalle storie di settore e di interrogarsi sulle ragioni di tale oblio.
Ciò che è interessante notare a partire dai capi d’abbigliamento di cui sopra è che un progetto trascurato dalla storiografia del graphic design possa essere “salvato” da un’attitudine in voga nel mondo fashion, in particolare negli ultimi anni: quella dei rip-off di elaborati della comunicazione visiva avvertiti come parte di una cultura popolare, di una storia collettiva. I loghi in primis sono tornati a essere centrali nelle collezioni di moda e la loro “memificazione” – il loro essere citati come meme, invitando il fruitore a interpretarne tanto il riferimento originario quanto il nuovo messaggio – è diventata una maniera per riappropriarsi di simboli di storie passate e di immaginari condivisi. Marchi di alta moda, aziende di sportwear o streetwear sempre più spesso hanno guardato alla golden age della corporate identity degli anni sessanta-novanta come a un ricco bacino a cui attingere. Tuttavia, la capacità di “campionare” tali artefatti non appartiene solo alla moda oggi. A conferma di ciò, nel 2017 la crew milanese di skater Chef Family GSF, riproponendo alcuni simboli storici del calcio azzurro degli anni novanta attraverso il proprio merchandising,[9] ha incluso anche il logo di Patrizia Pataccini tutt’oggi presente nell’header del sito web del collettivo. Effettivamente, dai fumetti alla trap, dalle fanzine illustrate all’arte, questo trend è riscontrabile in diversi contesti e sembra essere la naturale evoluzione tanto della nostalgia vaporwave quanto della meme-revolution attiva sui social.
Se da un lato questa tendenza a decontestualizzare e a citare insita nella moda invita a guardare alla storia delle comunicazioni visive da un punto di vista inedito, dall’altro i casi di memificazione sono accomunati dalla rinuncia ad approfondire e raccontare l’autorialità di molti dei loghi riproposti. D’altronde, l’atteggiamento opposto, quello cioè di concentrarsi sul racconto degli autori e dei singoli designer spesso ha reso le storie della grafica prive dell’analisi della dialettica tra graphic design e società. Da questo punto di vista, anzi, proprio la rinuncia ad accreditare l’autorialità di tali layout grafici fa riflettere. Se la storia della grafica – come pure il panorama dei graphic designer più in generale – si è mostrata spesso più propensa a evidenziare e incensare figure “eroiche” e a canonizzare correnti e stili formali più che ad approfondire la vita degli elaborati visivi e il loro rapporto con gli utenti finali e la società, l’approccio proposto dai marchi di moda in primis ci invita a leggere la storia del graphic design in maniera meno autoriale.[10]
All’autorialità come valore discriminante per salvare o dimenticare un progetto grafico, questo approccio sembra preferire il fattore della permanenza nella memoria collettiva. In questo modo, attraverso quello che si potrebbe definire meme-dernismo – cioè la capacità di trasformare in meme identità visive o elaborati appartenenti nella gran parte dei casi alla lunga stagione del modernismo nel graphic design – marchi come Lack of Guidance, Iuter e No Kiddin’ NYC riscoprono sia progetti già analizzati dalla storiografia del design sia storie totalmente dimenticate. I rip-off possono diventare quindi un’occasione per includere nella storia della grafica casi studio ed elaborati che, seppur non pionieristici, sono entrati nella memoria collettiva di un’intera nazione e di un pubblico internazionale, quello sportivo.
Inoltre, è emblematico che siano i loghi della golden age della corporate identity – di quel momento in cui gli auspici modernisti si traducevano in più o meno meticolosi manuali di identità visiva – a essere campionati, modificati, memificati; proprio gli elaborati che più di altri nella storia del graphic design hanno contribuito a raccontare in maniera autoreferenziale il grafico come regista di architetture complesse, come artefice della coordinazione visiva di un marchio, come figura capace di prevedere e controllare la vita e la diffusione di un logo nella società. I grafici attraverso i manuali di identità visiva si auspicavano di normare la diffusione dei loghi in differenti contesti tentando di evitare possibili errori di applicazione da parte degli utenti finali. Il meme-dernismo ripescando e citando i trademark aziendali finisce per minare la graniticità dei manuali di corporate identity, riportando invece l’attenzione sul ruolo degli utenti finali nella vita di un artefatto visivo.
Rip-off come quelli realizzati da Lack of Guidance, Iuter e No Kiddin’ NYC con il marchio FIGC di Patrizia Pataccini sono utili per guardare alla storia della grafica e in particolare alla sua stagione modernista con altri occhi: sganciandosi dai parametri estetici “da grafici” o da quella che Steven Heller chiama “lente formale”,[11] evitando di spendere altro tempo nella ricerca disperata di autori e nella mitizzazione di designer e concentrandosi invece sulla diffusione degli artefatti, sulla loro permanenza nella memoria collettiva, sul ruolo dell’utente finale nel tenerli in vita e nel riverberarli.
Suona strano auspicare il superamento del concetto di autorialità a partire da un caso studio realizzato da una designer che finora non è stata neppure raccontata nelle storie della grafica, – sorte comune a numerose professioniste donne precedenti, contemporanee e successive a Patrizia Pataccini.[12] D’altra parte, raccontare le vicende della designer allargando l’inquadratura può offrire uno sguardo più completo e trasversale anche sulla sua autorialità. Detto in altre parole: a cosa servirebbe parlare del rigore progettuale di Patrizia Pataccini senza parlare del rigore di Roberto Baggio o di quello di Luigi Di Biagio?