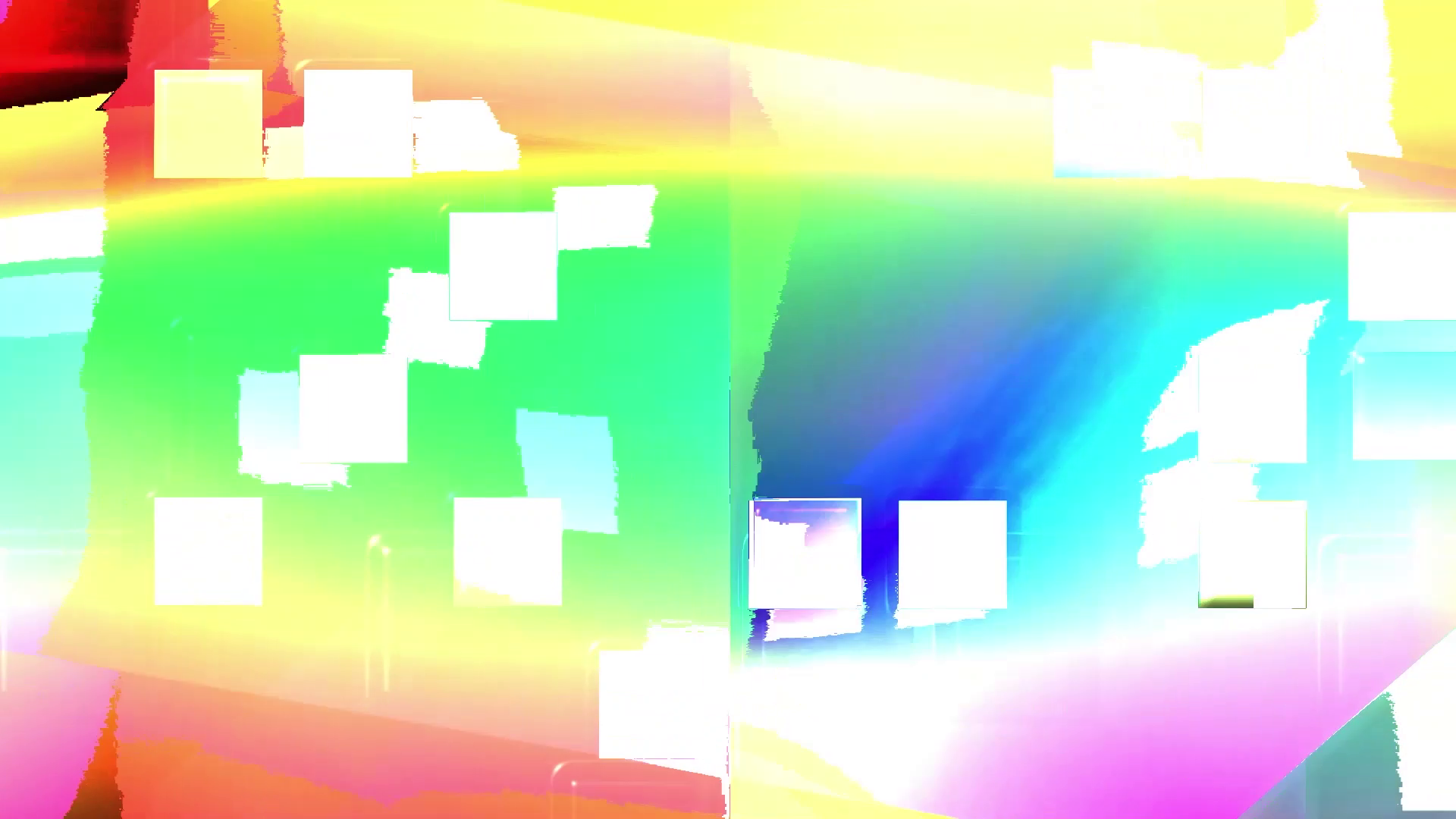

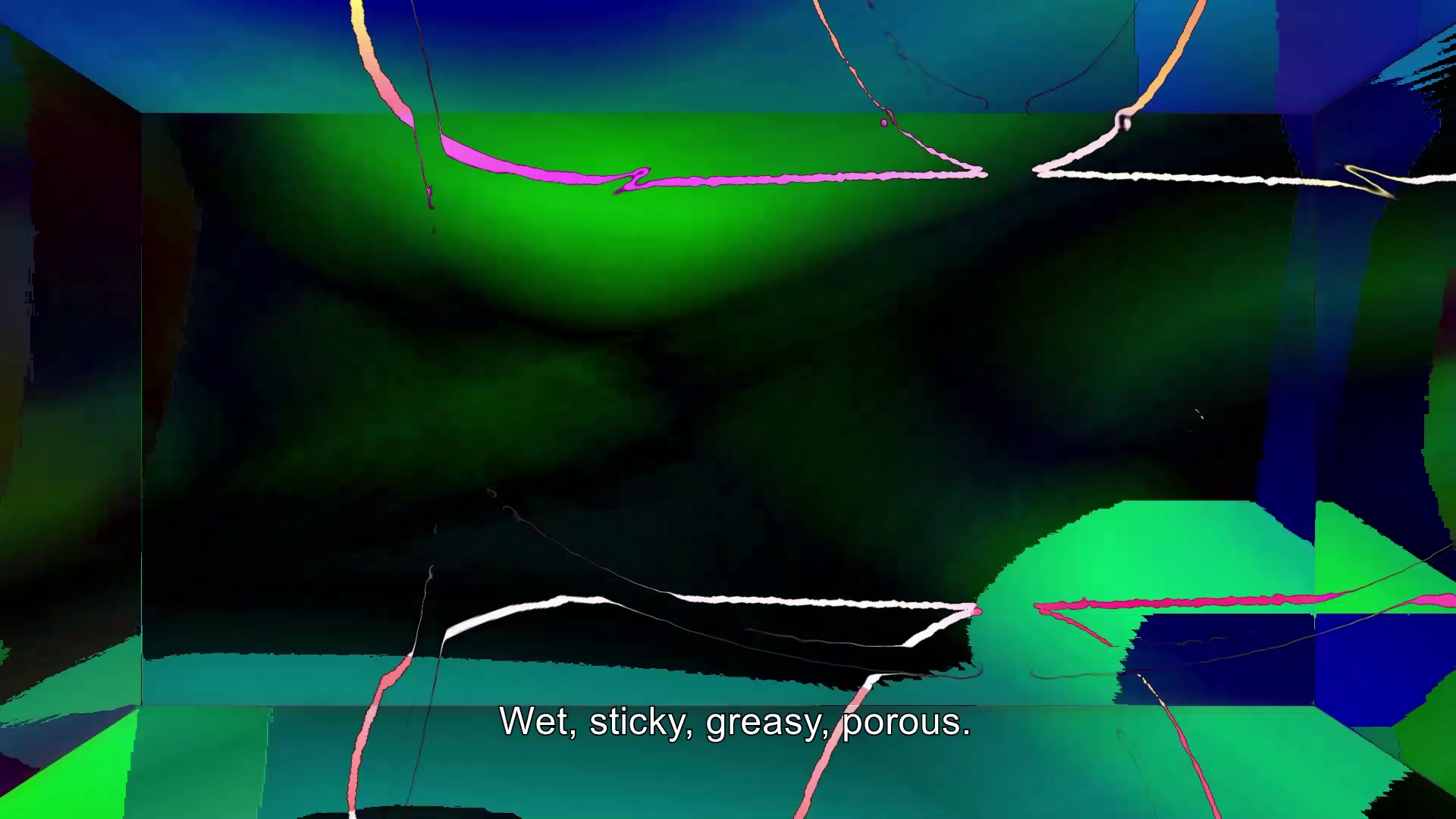

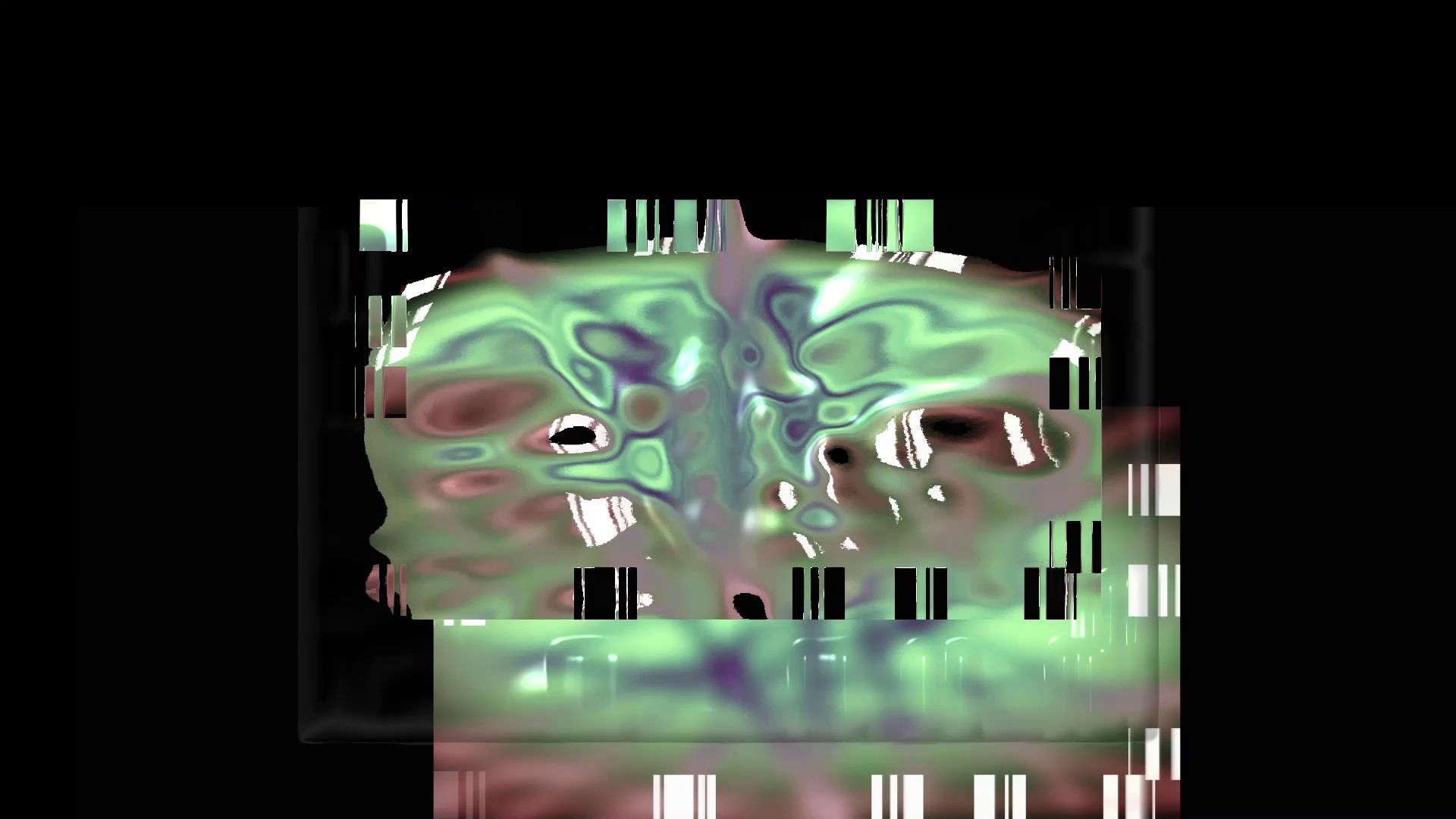
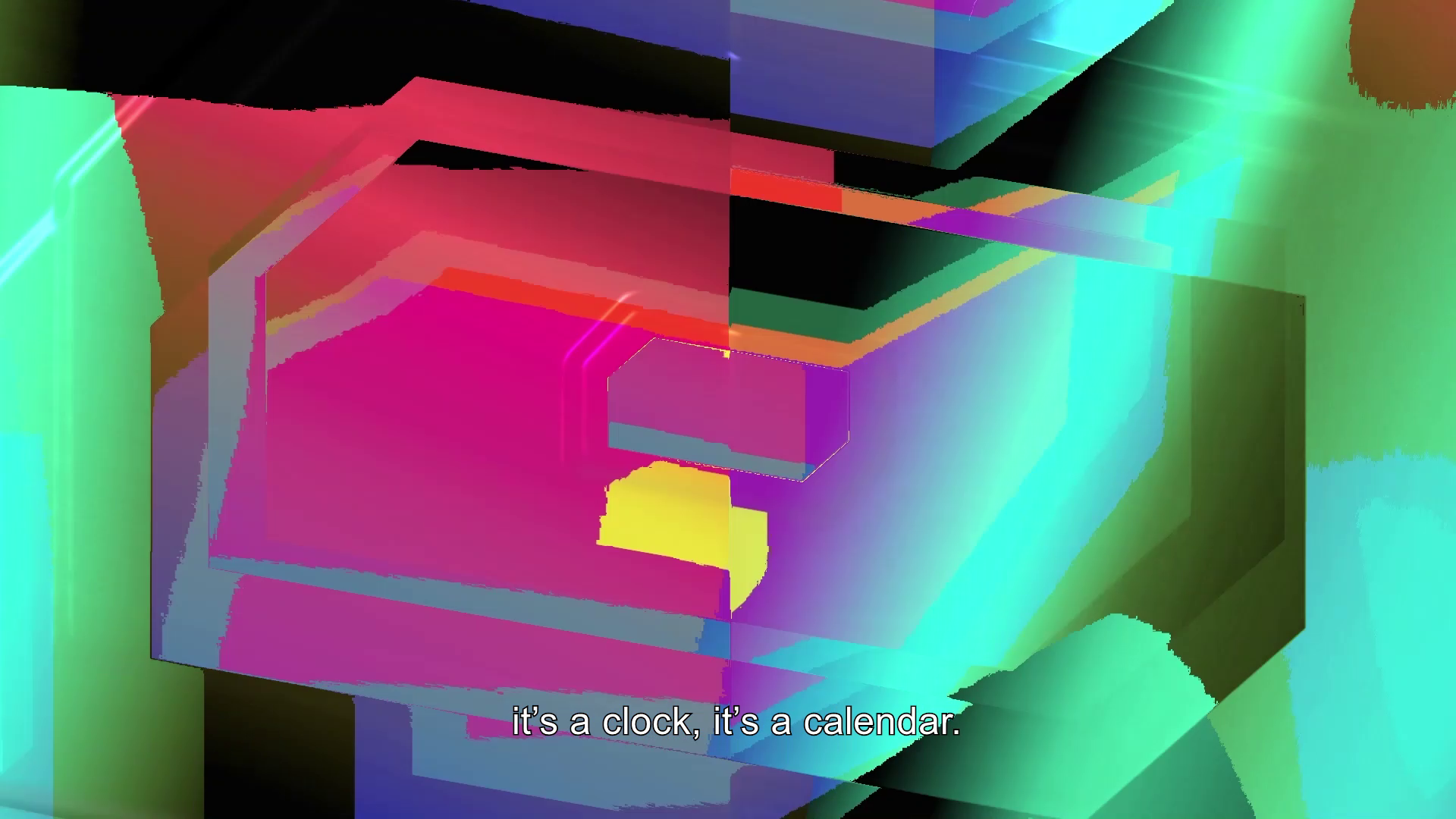

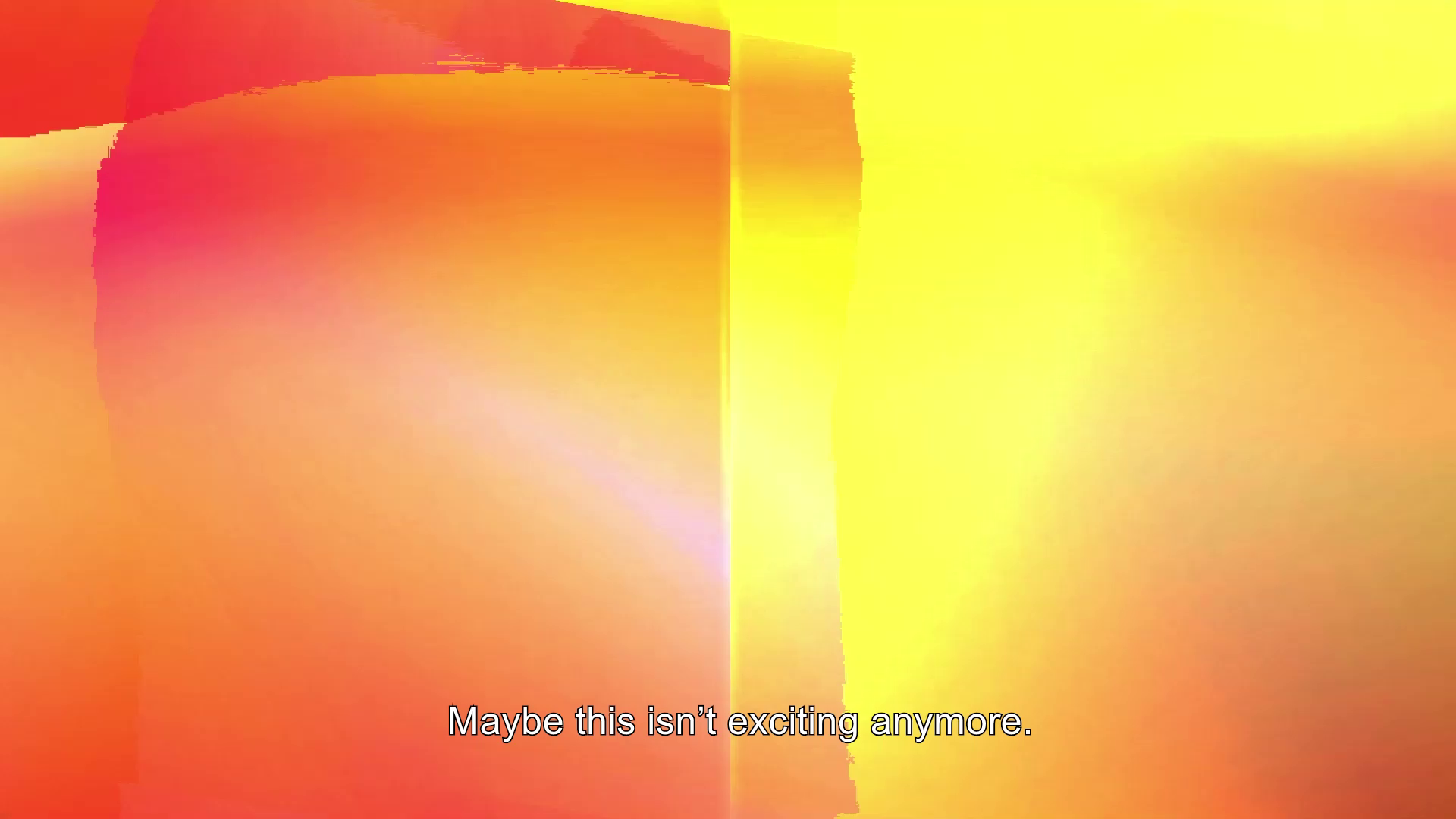
Stranamente soddisfacente: giocare a fare il designer
Alessandro De Vecchi,
Aprile 2021
È il primo aprile del 2018 quando Google, nel contesto della Design Week di Milano, presenta Softwear: un’installazione curata da Lidewij Edelkoort, all’interno della Galleria Rossana Orlandi. Tra tappeti morbidi, arazzi di colori pastello, smartphone e assistenti domestici, Softwear racconta una nuova relazione tra software, hardware e ambiente circostante. Il software informa il computer, si legge nei materiali di comunicazione, proprio come il Softwear forma lo stile di vita del lavoratore contemporaneo, in cui lavoro e tempo libero risultano sempre meno distinti. «Il futuro del nostro lavoro è destinato a cambiare: per risparmiare tempo e denaro e massimizzare l’energia e la produttività, cominceremo a lavorare un po’ da casa, nella nostra mente.» continua Edelkoort. L’idea del Softwear nasce già nel 1998, inquadrando la tendenza a sovrapporre sempre più lo spazio della casa, privato, con lo spazio del lavoro, l’ufficio. Nell’ottica di Google l’intero progetto è propedeutico alla promozione dei suoi nuovi prodotti, che integrano una componente soft nel design proprio per sposarsi perfettamente con l’ammorbidimento dello spazio domestico. L’assistente Google, le cover per smartphone e gli smartphone stessi diventano più confortevoli, pacati, soffici, inseriti perfettamente tra gli oggetti altrettanto comodi della casa, proprio per diventare spazi in cui sedersi, sdraiarsi, appoggiarsi mentre si lavora. In una parola: più confortevoli. Il raggio d’azione di Softwear non si limita a ciò che generalmente consideriamo tecnologia, ma include anche l’arredamento e il guardaroba, prefigurando lo sviluppo, già in atto, di un vero e proprio nido domestico.
Se l’idea canonica di ufficio imponeva l’esistenza di spazi separati dedicati a specifiche attività e garantiva al lavoratore una serie di servizi utili al lavoro stesso, lo spazio domestico rappresenta un modo totalmente diverso di approcciarsi al lavoro. C’è un elemento che ha permesso più di ogni altro la nascita e la diffusione dello smart working e della “flessibilità” lavorativa: lo spazio digitale dell’interfaccia.
Quando si lavora da casa, ogni luogo diventa un possibile spazio di lavoro (le immagini di Softwear ci mostrano persone che, avvolte da morbide coperte, lavorano al computer sdraiate su divani e letti) perché è l’interfaccia stessa a rappresentare questo spazio. Ma se lo spazio-tempo dell’ufficio scandiva le fasi del lavoro, lo spazio-tempo digitale non ha orari: esiste sempre, «sia come attualità (la mail a cui si sta rispondendo), sia come potenzialità (la notifica rossa delle mail non ancora lette)»[1]. L’ufficio diviene metafora[2] e l’interfaccia uno spazio perennemente adibito al lavoro che, per funzionare, trae linfa vitale dal progressivo adattamento dei luoghi della città alle sue personali necessità: non solo caffè e hotel, ma smart cities, la cui connettività perenne consente alle interfacce di funzionare dovunque e sempre[3]. L’interfaccia non si limita a concretizzarsi come condizione necessaria all’attività lavorativa, ma diventa anche l’unico modo tramite cui il lavoratore può imparare a controllare sé stesso e il proprio tempo.
Dopo aver cambiato il modo in cui il designer si approccia alla ricerca, divenuta più simile a una ricezione semipassiva di contenuti forniti da un algoritmo, e alla progettazione, influenzata dagli stessi software utilizzati, le interfacce hanno trasformato anche la dimensione gestionale e organizzativa del designer imprenditore di sé stesso.
Dal momento che il lavoro immateriale è per sua stessa natura difficile da quantificare, le interfacce tentano di dare innanzitutto una forma finita alla produttività, imponendo una scansione temporale del lavoro e assicurando una produzione continua. Perdere il controllo non è un’opzione: il lavoro raggiungerà il lavoratore ovunque egli sia, rendendo il tempo una costante opportunità per produrre. Anche lo svago, spesso concepito come l’opposto della produttività, viene fagocitato e disinnescato da questa logica, rivelandosi invece un suo importante alleato. Il godimento è infatti il centro della nuova economia delle interfacce, dal momento che queste ultime sono riuscite a integrarlo perfettamente nei propri sistemi. Nel contesto economico globale il godimento può essere produttivo o improduttivo[4] e nonostante il primo venga considerato funzionale alle strutture sociali e il secondo insensato, sono in realtà complementari poiché «nell’insieme mostrano gli effetti sociali del godimento e concorrono alla costruzione della moderna soggettività capitalistica»[5]. La dimensione “imprendicaria” risente molto del tema del piacere, poiché la retorica stessa della Silicon Valley presenta il piacere come uno “stato di natura”, instillando nell’uomo la convinzione che il godimento sia portatore di libertà e autonomia in quanto sintomo della soggettività: «più godiamo, più diventiamo soggetti capitalistici individualistici»[6].
Così le interfacce, attraverso precise scelte grafiche e interazioni, si fanno più soft per adattarsi al nuovo ecosistema domestico, più giocose per catalizzare il godimento e più confortevoli per tranquillizzare l’utente. La produttività diventa quindi una vera e propria forma estetica indirizzata alla creazione di una finta forma di autocontrollo. Rispondendo alla necessità dell’uomo di astrarre e ordinare il caos [7], questa estetica si dispiega sotto forma di grafici, task, elenchi, notifiche, indici, percentuali e icone, restituendo all’utente un’immagine chiara e comprensibile del proprio operato. Gli algoritmi gestiscono per noi gli aspetti caotici del lavoro configurandosi non più come semplici assistenti ma come veri e propri datori di lavoro invisibili, che controllano lo spazio dell’azione. Le interfacce alimentano così l’illusione che il lavoro possa essere sempre produttivo e ordinato, grazie a un’ambiguità intenzionale di fondo che pervade l’intero processo e nutre l’impressione che queste siano più reattive ed efficienti di quanto non lo siano in realtà.
Ma in che modo l’illusione di controllo, il godimento e la produttività convergono nelle interfacce? Nel contesto del software a scopo gestionale ritroviamo molti di questi temi a livello estetico, narrativo e metaforico, assistendo a un fenomeno per cui la gestione del proprio spazio, del proprio tempo e delle proprie risorse lavorative sfrutta la dimensione del godimento per rendersi più pervasiva. Ogni interazione effettuata tramite un’app o un software per la gestione della produzione lavorativa è connessa a un piccolo godimento intimo che diventa a sua volta produzione in tempo reale (è satisfying mettere il check a una task). Allo stesso tempo il godimento prodotto dalla distrazione gioca un ruolo fondamentale nel sublimare l’alienazione lavorativa, impedendo un giudizio critico verso le proprie condizioni. Anche laddove si cerchi riparo nell’ozio, si finisce per alimentare una realtà illusoria, ordinata e coerente, alla quale dobbiamo prima o poi tornare a far riferimento, lavorando: «distrarci durante l’attività lavorativa serve a conferire senso, valore, importanza al lavoro stesso»[8] (il T-Rex di Chrome ne è un perfetto esempio). È per questo che nei software per il project management si fa sempre più presente una componente di gioco. È quella che ormai è nota come gamification, un processo per cui i prodotti che danno forma a interi settori economici (la sharing economy) assumono forme e regole originarie del mondo dei videogiochi. L’interfaccia diventa simile a un gioco nelle forme e nell’interazione, andando a sovrapporsi al godimento improduttivo. Se lavorare è sempre più simile a giocare, decade anche la distinzione tra momento d’ozio e momento di lavoro, a favore di un ibrido tra i due momenti che risulta estremamente pericoloso. La distinzione tra lavoro e gioco si erode a causa di due fenomeni paralleli: nei videogiochi compiamo azioni sempre più simili a veri e propri lavori e le interfacce con cui lavoriamo somigliano sempre di più a videogiochi. Servizi come Uber, ad esempio, o Deliveroo, coinvolgono l’utente in dinamiche ludiche, astraendo al tempo stesso qualsiasi operazione scomoda come quella del pagamento, eliminando la complessità e le interazioni non necessarie. La costruzione di questo strato dell’interfaccia su molte aree della cultura e della società funziona e si diffonde grazie al ruolo di arbitro della fiducia ricoperto dall’interfaccia stessa. Nel contesto del progetto possiamo individuare dinamiche simili, tra cui quella dell’intimità. Quando utilizziamo un software per il project management come Monday, Basecamp, Trello o Asana stiamo affidando una parte del nostro lavoro a un servizio, riponendo la nostra fiducia in esso e nella sua capacità di mediare le nostre interazioni sociali. La logica è simile a quella delle app di food delivery: l’imbarazzo di farsi consegnare un pranzo viene lenito dall’interfaccia che ha mediato questa interazione. Allo stesso modo assegnare task, spostare le deadline e mettere pressione a un collega sono tutte azioni che vengono delegate all’interfaccia, capace di semplificare i processi e astrarli. L’interfaccia presiede così sia alla gestione di noi stessi che all’interazione lavorativa con i nostri collaboratori, rendendo il lavoro in ultima analisi più godibile. Il godimento, reso possibile dalla gamification imperante di questi sistemi, riesce a spingere il lavoratore a dare il massimo tramite un sistema di ricompense e micro-scariche di dopamina. Tra metriche, misurazioni e punteggi, gli strumenti gamificati incentivano anche la competizione, creano distacco dalle attività svolte e costringono a focalizzarsi sul breve termine. Quando si completa un’attività assegnata su Asana, la casella brilla velocemente gratificando l’utente mentre un piccolo unicorno colorato attraversa lo schermo lungo una diagonale. Asana permette inoltre di controllare in tempo reale quanto velocemente il team si sta avvicinando al prossimo obiettivo di progetto; alcuni indicatori verdi, gialli o rossi segnalano se il progetto sta procedendo rispettando il programma e le deadline definite; i lavoratori sono valutati in tempo reale in base alla loro produttività e quantificati in grafici e punteggi. L’intero flusso lavorativo, dal lavoratore autonomo alla grande azienda, è rappresentato come il tabellone dei risultati di un videogioco che si aggiorna in tempo reale. L’unicorno arcobaleno di Asana ci mostra un ulteriore aspetto fondamentale del processo di gamification, che per certi versi riprende il tema del Softwear di cui si è parlato in precedenza: la tendenza delle interfacce a divenire sempre più cute. Questo termine si riferisce al gusto estetico delle interfacce contemporanee, fatto di totale candore, pulizia, forme arrotondate e soluzioni grafiche e illustrazioni essenzialmente infantili[9]. Non si tratta soltanto di una semplice moda passeggera, ma di una reazione a un’era dell’ansia [10]. Se un tempo la cuteness era vista dal mondo del design come frivola e poco seria, oggi è diventato un tema ricorrente nel lavoro di studi indipendenti e nel circuito internazionale non solo dell’arredamento, ma di tutte le aree del design, tra cui anche quello grafico e delle interfacce. La sua crescente popolarità deriva da alcune leggi della biologia evolutiva per le quali i tratti tipici della morfologia infantile (occhi e testa grandi, gambe e braccia corte, rotondità) generano una risposta emotiva che porta a prendersi cura dell’oggetto in questione. Allo stesso modo, sedie, sgabelli e lampade da tavolo vengono progettati tenendo a mente queste regole mentali che portano al desiderio di volerli abbracciare, stringere o giocare con loro. Uno studio del 2011[11] ha esplorato come l’astrazione di queste morfologie nel product design possa portare a un maggior coinvolgimento da parte degli utenti, aumentando in ultima analisi la user satisfaction. Le interfacce non sono escluse da questa metamorfosi, come dimostra l’imponente rebranding di Google, nel quale quattro cerchi colorati si muovono giocosamente costruendo forme e icone facendo perdere anche al logo le spigolosità di un tempo, o l’altrettanto importante restyling di Facebook che, come molte altre realtà, ha adottato il linguaggio dell’illustrazione cartoonesca per comunicare. Dropbox ha rinnovato la propria identità visiva nel 2017 proponendo colori vivaci e giocosi, illustrazioni con creature buffe e animali composti da una molteplicità di pattern colorati e tratti a matita; Toggl, uno strumento per controllare il monte ore dei propri progetti, così come in passato possedeva un’identità basata sulle azioni bizzarre di mostriciattoli colorati assemblati con della pasta modellabile, oggi propone un’identità che riprende quel concept avvicinandosi più al mondo dell’oddly satisfying. Anche Google Home o Alexa sono oggetti tondeggianti, dotati di superfici morbide e abbastanza grandi e pesanti da essere presi in braccio come cuccioli. I pattern mentali biologici che portano a reagire in un certo modo all’esposizione alle forme infantili sono gli stessi che rendono le interfacce attraenti ai nostri occhi, consentendoci di godere nel prenderci cura di esse (come se fossero bambini in cerca di attenzioni). I software, le app, i web tools, da Asana a Gmail, da Dropbox a LinkedIn, diventano così dei controllori algoritmici estremamente elaborati avvolti da involucri amichevoli, che si presentano come assistenti intelligenti perennemente attivi.
Estratto da Less Exciting Times. Il designer come estensione del software. Tesi di laurea magistrale di Alessandro De Vecchi in Design della comunicazione, A.A. 2019/2020 – Politecnico di Milano. Relatore: Francesco Ermanno Guida.
Note:
[1] Silvio Lorusso, Entreprecariat. Siamo tutti imprenditori. Nessuno è al sicuro, Krisis, Brescia 2018, pp. 100.
[2] Cfr. Lev Manovich, Software Culture, Olivares, Milano 2010.
[3] Cfr. Evgenij Morozov, Silicon Valley. I signori del silicio, Codice Edizioni, Torino 2017.
[4] Cfr. Alfie Bown, Capitalismo & Candy Crush, Nero, Roma 2019.
[5] Ivi, pp. 19.
[6] Ivi, pp. 27.
[7] Cfr. Ed Finn, Che cosa vogliono gli algoritmi. L’immaginazione nell’era dei computer, Einaudi, Torino 2018.
[8] Alfie Bown, Capitalismo & Candy Crush, Nero, Roma 2019, pp. 60.
[9] Silvio Lorusso, Entreprecariat. Siamo tutti imprenditori. Nessuno è al sicuro, Krisis, Brescia 2018.
[10] Diana Budds, The rise of round. Cute furniture is a reprieve from our age of anxiety, “Curbed”, https://www.curbed.com/article/round-chunky-cozy-furniture-design-trends.html – Ultimo accesso: 20 febbraio 2021.
[11] Andreas Herrmann, Helmut Leder, Linda Miesler, Isn’t It Cute: An Evolutionary Perspective of Baby-Schema Effects in Visual Product Designs, “International Journal of Design”, 5, 17–30.